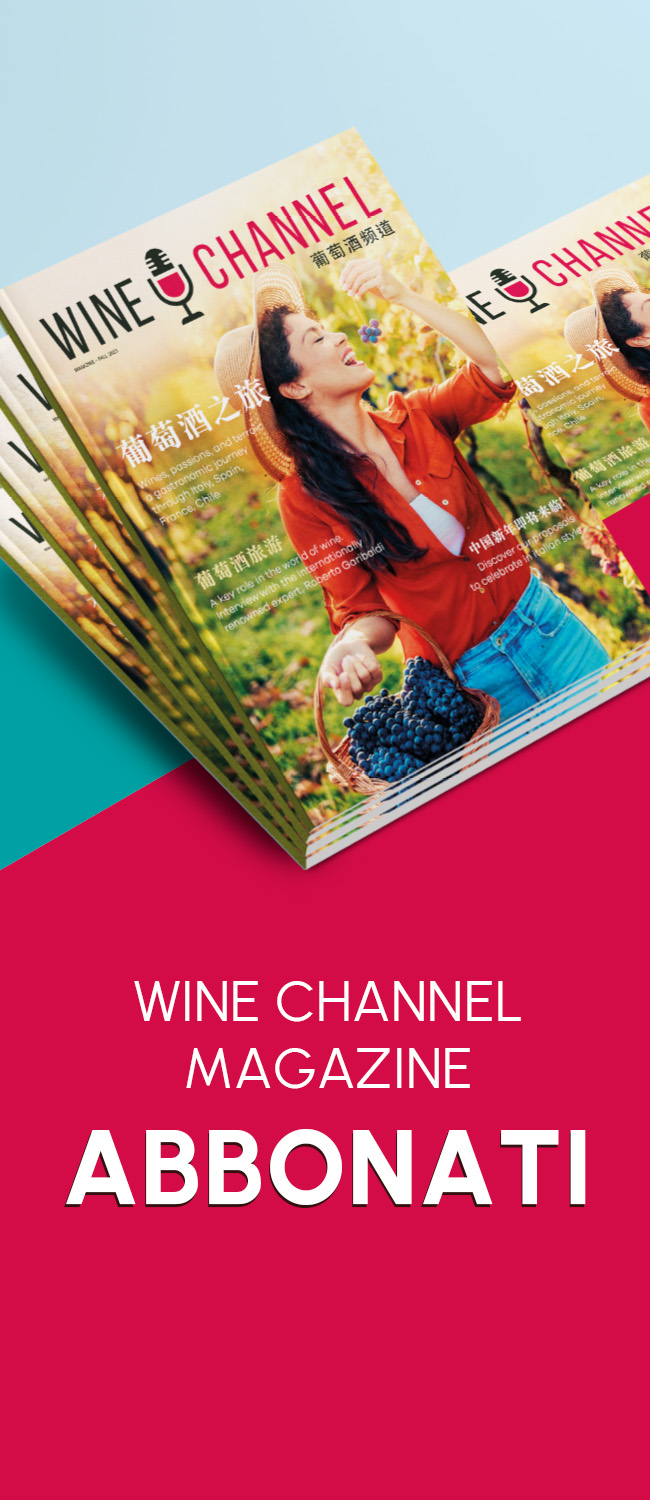La Costa d’Amalfi, con la sua sinuosa morfologia tra mare e montagne disegna molteplici itinerari per imperituri luoghi del viaggio; inteso, quest’ultimo, nell’accezione di scoperta, peregrinazione, quotidiana esperienza e opportunità di crescita, sia personale che economica. Su questa scagliosa tela fatta di scogliere a picco sul mare, montagne di acque riflesse, terrazze a uva, ortaggi, limoni e villaggi di pescatori, si inserisce la figura dell’eroe vignaiolo: un figlio di Prometeo, così come della ninfa Amalfi, amante di Eracle, e ancora di Leucosia, Partenope e Ligea, indomite sirene a dominio di questo spicchio di mondo marino.
Dalle suggestioni tardo settecentesche del pittore Christoph Heinrich Kniep, nel suo viaggio tra Capri e Punta Campanella, a quelle di Goethe, tra gli scogli delle sirene di Capri, fino ad arrivare alle poesie del teutonico eroe fuggitivo August von Platen, ogni singolo racconto della Costa d’Amalfi esprime un traboccare di natura, estrema e sublime, suggerirebbe il pittore romantico Caspar David Friedrich, che assoggetta e annichilisce la bucolica idea della Campania felix tratteggiata da Plinio il Vecchio e da Virgilio.
È un romanticismo di uomini e ambiente quello che si svela, titanico, prepotente e “tremendo”, agli occhi dei viaggiatori dei Grand Tour così come a quelli dei turisti di oggi; e chi ama il vino, ma soprattutto la sua genesi mediterranea, non può che abbeverarsi a questa fonte.
Le viti, a piede franco, talvolta quasi centenarie e talaltra selvagge come le notti di Licaone d’Arcadia, sono l’androgina voce della costiera: graffiante, frammentata e cangiante. Le terrazze sono, allo stesso tempo, l’Olimpo e l’Averno dell’eroe vignaiolo (su queste sponde talvolta anche pescatore): un patchwork di viti, limoni e olivi aggrappati alla terra, poca, ma follemente allungati verso l’ammaliatore canto del mare.
Un viaggio tra storia e produzione
Antico il retaggio della coltivazione della vite, che risalirebbe all’860 d.C., su fondi sottratti al bosco. Documenti storici della città di Amalfi, risalenti a quell’epoca raccontano già di una sorta di zonazione: «peciam de vinea in regina maioren (una porzione di vigneto nell’area della regina maggiore)» oppure «pecia de terra cum vinea in locus beteri (un pezzo di terra con vigneti nel luogo di beteri» e ancora «mostram vineam seu terris campis silvis arboribus fructiferis et infructiferis in Oecara (mostrami vigneto o un terreno nei campi di boschi con alberi da frutto o improduttivi a Oecara)».

Erano i secoli dell’Alto Medioevo, della ripresa dalla caduta, più di 380 anni prima, dell’Impero Romano d’Occidente: un periodo in cui, qua e in là lungo la Penisola, si consolida il rifiorire di una viticoltura organizzata, sebbene ancora profondamente promiscua con le altre colture. Diversi documenti inerenti il Mezzogiorno d’Italia tra il IX e X secolo e fino al 1025, testimoniano di un incremento del rapporto tra la coltivazione della vite e altre destinazioni agricole da uno a uno intorno al 900 fino a tre a uno nel 1025, per poi, secoli più tardi, tra il 1600 e il 1700 dominare, letteralmente, la Costiera. Questa presenza fitta e capillare, comunque, non deve trarci in inganno, facendo immaginare quantità e specializzazione. La dimensione, prima e dopo l’Unità d’Italia, rimane sempre contenuta; sia in termini di proprietà fondiarie sia in termini di quantità di vini prodotti.
Oggi è la DOC Costa d’Amalfi a dettare legge sulla produzione enologica, con le tre sottozone di Furore, Ravello e Tramonti. Il territorio abbraccia 13 comuni, ubicati su differenti altitudini, lungo il versante meridionale della catena dei monti Lattari, che si protende verso il mare, dividendo il Golfo di Napoli da quello di Salerno. Per la sua bellezza naturalistica, questo tratto di costa, nel 1997, è stato proclamato patrimonio dell’umanità UNESCO. Le uve allignano, più o meno ordinate, su terrazzamenti raggiungibili, spesso, percorrendo stretti sentieri completati da tortuose rampe di scale, sorretti da muri di pietrame a secco. Macère è il nome di questi antichi sostegni e la loro realizzazione prevede l’esclusiva sistemazione delle pietre l’una sull’altra, senza alcun ausilio cementizio. Nei secoli, per sistemare tali architetture, si è dovuto, manualmente, portare terra in modo da riempire i terrazzamenti e dare definitiva forma alla cuna di ogni singola vite.

Le forme di allevamento sono a controspalliera e pergola, con potature corte, lunghe o miste. Gli impianti, poi, sono tradizionali e possono essere a raggiera atipica (lasciando i lunghi tralci distribuiti sulle pertiche orizzontali come raggi di una ruota) con pali di castagno a sostegno dei tralci (pali decorticati a mano a inizio primavera, stagionati almeno un anno, quindi bruciati in testa) oppure con singolo palo tutore che tiene legato, attraverso un ramo di salice, più ceppi.
Il disciplinare stabilisce che i vigneti, idonei alla produzione di vino, debbano essere coltivati su terreni collinari a un’altitudine non superiore ai 650 metri s.l.m., mentre la produzione massima per ceppo non deve essere superiore a 7 chilogrammi per le tipologie Rosso e Rosato e 8 per il Bianco, con densità d’impianto non inferiore a 1.600 viti.

Il terreno d’origine si è formato alla fine del pliocenico, quando prende forma la struttura dei rilievi che culminano con la vetta del Monte Faito (1.279 metri s.l.m.). La piattaforma geologica è rappresentata da rocce dolomitico-calcaree, affioranti su più punti in superficie, che costituiscono la base di tutti i suoli coltivabili della Costa d’Amalfi. Queste rocce sono state ricoperte, in tempi più recenti, da stratificazioni vulcaniche composte da turece, sabbia, cenere lapillo e da terra vulpegna, terreno argilloso del colore del manto della volpe.
Protagonisti, insieme ai vignaioli, di questa antica e originale produzione enoica sono i vitigni locali: unici, ultracentenari per origine e, come si è già detto, a piede franco. Fenile, Ginestra, Pepella, Ripolo, Tintore e Tronto si “mescolano” qui con Aglianico, Biancolella, Falanghina, Piedirosso, Serpentaria e Sciascinoso, formando uno scenario tra i più articolati e tipici dell’ampelografia del nostro Paese.